Tito e Mena (Potito e Filomena) – ma anche gli amici Poldo e Gina – sono gli attempati protagonisti della nuova commedia dei “Teatroci”, dal titolo: L’AMOR SENZA BARUFFA FA LA MUFFA.
Dopo quasi 50 anni di matrimonio, qualche scricchiolio affiora anche nella coppia più affiatata del mondo, ma l’affetto e l’amore prevalgono sempre su tutto, abbattendo ogni ostacolo. Anche quelli della salute.
Soprattutto se, in mezzo all’amore, c’è anche un po’ di baruffa. Giusto per annoiarsi…
PRESTO TORNEREMO A TEATRO!!!!!
Mese: Maggio 2020
29 maggio 1985, la partita della morte
Articolo di Marino Bartoletti
Quando tornai in video – allora, oltre che essere inviato del “Guerin Sportivo,” conducevo la “Domenica Sportiva” – dissi testualmente: “Tre giorni fa ero all’Heysel. Proprio per questo mi auguro, nella mia vita, di non doverne parlare mai più”. E invece ne parlai tante altre volte (e sarebbe stato giusto così): ma sempre con un dolore e uno sgomento che 35 anni non hanno minimamente scalfito . Quando mi capitò di tornare in quello stadio nel 2000 per la partita degli Europei fra Italia e Romania provai un sincero voltastomaco nel vedere quel sepolcro imbiancato a festa e addirittura col nome cambiato
Non c’è un secondo di quel giorno che non abbia nitidamente negli occhi. Né, purtroppo, un secondo di quella notte: con tutte quelle bare allineate in un capannone illuminato in maniera innaturale, attraversato da un’umanità annichilita e sperduta. Persino il dolore era schiacciato dall’incredulità. C’erano fratelli, mogli, madri, padri, figli (almeno quelli che erano riusciti ad arrivare) che dicevano tutti la stessa cosa: “L’avevo visto stamattina partire felice….”. E poi compagni di viaggio che avevano vissuto assieme l’attesa di una festa e che avevano gli occhi fissi nel vuoto. Molti coi vestiti ancora lacerati
L’ho raccontata troppe volte quella tragedia per aver promesso a me stesso di non “volerne parlare più”. Era dal mattino che si capiva come la situazione fosse assolutamente fuori controllo: la Grand’Place aveva il pavimento lastricato di cocci di bottiglie svuotate e gettate dagli inglesi. La polizia sorrideva agli hooligans e “rimproverava” i tifosi juventini che facevano chiasso. Il resto è inutile raccontarlo: si ebbe subito la sensazione che gli occupanti del settore Zeta – la parte più mite e “tranquilla” del tifo juventino – messi irresponsabilmente a contatto con gli avversari più animaleschi, sarebbe stata schiacciata alla prima folata di violenza. Beato chi cadde dal quel muro marcio e si ferì soltanto: quelli che non ne vennero schiacciati morirono contro le reti del campo verso il quale avevano cercato la salvezza (con la Polizia prima a piedi e poi a cavallo che li respingeva a manganellate).
Io lasciai la tribuna per andare verso gli spogliatoi. Trapattoni chiese a me cosa fosse successo: la squadra, in un primo tempo non ebbe la percezione della tragedia. “Se hai un telefono chiami tu la Paola per dire che stiamo bene?” “Sì tranquillo Giovanni, appena torno su”. Ricordo Edoardo Agnelli stranito e inebetito. In Italia, per la voce di Bruno Pizzul, si cominciava a capire. Corsi fuori. Vidi l’operatore della Rai di Torino Isoardi riprendere i primi morti schiacciati: chi a terra, chi adagiati su transenne e cartelloni pubblicitari. Non so se tutte quelle immagini siano mai andate in onda. Vidi persino i primi gesti di pietà della Polizia. Vidi l’esplosione di un sentimento – la disperazione – che da un luogo di sport dovrebbe essere bandito per definizione.
Scrissi un reportage pieno di rabbia. La stessa che provo ancora quando negli stadi si “inneggia” all’Heysel (e ovviamente per ogni “risposta” eguale e contraria di chi pensa che una partita di calcio sia un esercizio da bestie e non da uomini). Non posso augurare a chi non ha capito cosa sia stata quella tragedia di poterne un giorno assaporare lo stesso fiele. Però vorrei essere creduto, questo sì: da chi ancora non ha compreso che il male assoluto non è un rigore negato, ma la nostra predisposizione all’odio!
La morte di Walter Tobagi: “Hanno odiato l’uomo sbagliato”
Articolo di Marino Bartoletti
Nel 1980 lavoravo ancora al “Giorno”. Alle spalle del grande open space della redazione sportiva c’era quello degli “spettacoli”. Un pomeriggio entrarono tre poliziotti in borghese: vennero a informare Morando Morandini, uno dei più specchiati e mansueti galantuomini che abbia mai conosciuto (oltrechè, all’epoca, il più accreditato e stimato critico cinematografico italiano) che suo figlio Paolo era un assassino: che era appena stato arrestato per la morte di Walter Tobagi. Un giornalista come lui: e come me.
Aveva 56 anni, Morando. Quando uscì in mezzo a quegli agenti ne dimostrava 100. Nel tormento, si stava probabilmente chiedendo in cosa avesse sbagliato. Probabilmente in nulla. Aveva fatto tutto la vigliaccheria di suo figlio: e dei suoi cinque scellerati complici, a cominciare dal “capo” Marco Barbone, ventiduenne rampollo della “Milano bene” inebriato dall’infame desiderio di attuare chissà quale “giustizia proletaria”. Ma così cinico e pusillanime da “pentirsi” subito dopo l’arresto, usufruendo degli sconcertanti sconti che la legge aveva previsto per debellare il terrorismo. In pratica quasi tutta la “Brigata XXVIII marzo” (chiamata così per “onorare” i tre brigatisti sorpresi ed eliminati a Genova dai carabinieri del generale Dalla Chiesa) stette in galera solo per il tempo della carcerazione preventiva: Morandini e Barbone (che a Tobagi aveva sparato anche il colpo di grazia a una tempia) vennero condannati a poco più di otto anni – pena già inaccettabile per un delitto così vile – e immediatamente mandati a casa fra lo sgomento di tutti
Inutile ripercorrere la follia di quei tempi e di quegli uomini (la reiterata presenza mediatica di alcuni dei quali offende ancor oggi la civiltà di questo Paese). Tutti delitti incomprensibili, biechi, spregevoli, codardi, spesso senza senso: contro vittime sistematicamente inermi. Ma l’assassinio di Tobagi andò oltre la soglia più inimmaginabile della dissennatezza e della crudeltà. La “Brigata XXVIII Marzo” lo scelse proprio perché era il più indifeso di tutti. E lo ammazzò per poter fare quel salto di qualità che potesse far “promuovere” i suoi giovani componenti al rango di brigatisti rossi “effettivi”
Aveva 33 anni Tobagi: quasi due più di me che lo conobbi appena arrivai a Milano perché l’”Avvenire” in cui lavorava prima di passare al “Corriere d’Informazione” e poi al “Corriere della Sera” era nello stesso palazzo del “Guerin Sportivo” in Piazza Duca d’Aosta e ne divideva la rotativa. Amava parlare (e a volte anche scrivere) di calcio e quasi mi “invidiava” per quello che facevo. In realtà era uno dei più brillanti, preparati e intelligenti giovani giornalisti in circolazione: talmente bravo da sfondare subito in un mondo professionale nel quale era piuttosto difficile scalzare i baronati delle “grandi firme”. La consacrazione del “Corriere” lo fece decollare, anche se non rinunciò mai alla sua vocazione sociale e sindacale impegnandosi (forse anche troppo secondo qualcuno) alla ricerca di equilibri etici e professionali che disturbarono qualche collega
Poteva scrivere di tutto (di politica, di economia, di sindacalismo, di cronaca): fu in primissima linea nei reportage sul terrorismo. Soffrì molto nel raccontare l’assassinio del giudice Alessandrini, progressista come lui, puro come lui: come lui vittima sacrificale della follia umana (declinata in chissà quale “progetto”)
Lo vidi per caso proprio la sera prima che morisse: perché andai a una riunione al Circolo della Stampa che, per tanti versi, lo amareggiò parecchio. Gli spararono per strada alle undici della mattina dopo: era il 28 maggio di quarant’anni fa. La colpa, secondo qualcuno, fu proprio quella di essere un socialista che non capiva – ovviamente – anzi si batteva contro i deliranti concetti di “rivoluzione”. Ebbe il torto, questo sì, di aver sostanzialmente scritto che i brigatisti e gli aspiranti tali oltre che degli assassini erano soprattutto dei falliti. E i falliti, che sono sempre dei vigliacchi, gli spararono alla schiena
Il Cardinale Martini davanti alla sua bara disse a chi l’aveva ucciso: “Avete odiato l’uomo sbagliato”.
Gigi Simoni, l’allenatore gentiluomo
di Emanuele Perego
(zonacalciofaidate.it)
Gigi Simoni alzò al cielo all’età di 59 anni la Coppa Uefa, era il 6 maggio del 1998. La sua Inter batté la Lazio (3-0) al Parco dei Principi di Parigi.
E’ il trofeo più importante vinto dal tecnico emiliano. Massimo Moratti, patron dell’Inter, lo chiamò alla Pinetina nell’estate del 1997.
Luigi, detto Gigi, nasceva a Crevalcore, alle porte di Bologna, il 22 gennaio del 1939. Si è spento all’età di 81 anni dopo aver lottato per mesi, colpito da un ictus nel giugno dello scorso anno.
E’ stato un uomo misurato e pacato, quasi mai fuori misura, lucido e cristallino durante le interviste; con i giornalisti è stato disponibile e affabile.
Rimane negli annali del calcio lo scontro tra Ronaldo e Iuliano all’interno dell’area di rigore durante il match-scudetto tra Juventus e Inter (1-0), il 26 aprile del 1998. L’Inter invocò il calcio di rigore e, in quell’occasione, anche Gigi Simoni contestò con veemenza l’arbitro Ceccarini di Livorno. Il mister ricevette “la panchina d’oro” come miglior allenatore italiano della stagione.
Era considerato dai critici detrattori un “allenatore di provincia”, giunto sul palcoscenico del grande calcio in età matura, abituato a lottare per non retrocedere e mago delle scalate nella massima serie dal carattere schivo e arcigno.
Il suo gioco equilibrato era semplice e basilare ma estremamente sagace; le qualità dei singoli esaltati al servizio del collettivo. In molti lo rammentano temperato nella tattica e acuto nei rapporti interpersonali. Il legame stretto tra Gigi Simoni e Ronaldo (Il Fenomeno) era paterno, schietto, trasparente.
Lo ricordiamo passeggiare con la moglie Monica all’interno della Fiera di Milano durante una kermesse del mobile, con il suo fare gentile e garbato, non disdegnando le domande rispettose di appassionati e curiosi.
“Gigi era una grande persona, un grande uomo” dice Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, e aggiunge: “Per me è stato importantissimo, mi ha dato l’opportunità di giocare un quarto Mondiale”.
Iniziò da giocatore, vestendo le maglie del Mantova di Edmondo Fabbri, Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa. A Napoli vinse la Coppa Italia del 1961-62, mentre nel Torino formò la coppia con Gigi Meroni. Nel ruolo di centrocampista collezionò 386 presenze da professionista segnando 62 reti.
Nel 1975, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, cominciò una lunga carriera da allenatore, girando in lungo e in largo la penisola italiana. Conquistò 8 promozioni, una cifra record per il calcio nostrano, di cui 7 in Serie A con Genoa (1975-76 e 1980-81), Brescia (1979-80), Pisa (1984-85 e 1986-87), Cremonese (1992-93), Ancona (2002-03), infine una in seri C1 con la Carrarese (1991-92).
“Ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte”.
La data del Triplete.
Così comincia il comunicato dell’Inter sul sito ufficiale, che esprime il cordoglio della società nerazzurra alla famiglia e ai suoi cari.
Attenti, sto arrivando!!!!
Attenti, sto arrivando nel vostro bar preferito!
Dopo il successo di “Gentecheparla…dalla quarantena” durante il lockdown, torno con una piccola variabile che mi fa molto piacere: i bar hanno riaperto e cosa c’è di meglio di venire nel vostro bar preferito a parlare con voi e con il vostro amico barista (che i suoi grattacapi ce li ha di sicuro, ma tira avanti!)?
In diretta, a sorpresa, sulla mia pagina Facebook!

Stiamo combattendo il virus della paura!
Riaperti i locali cosa pensavate? Che le gente (con i pochi spiccioli rimasti in tasca) non andasse a prendersi un aperitivo o a mangiare una pizza? Bar e ristoranti dovevano rimanere vuoti??? Con le dovute cautele, certo…
Anzi, un buon segno: stiamo combattendo il virus della paura!
Ps. Chi vuol restare in casa, faccia pure. Ma non rompa le balle agli altri.
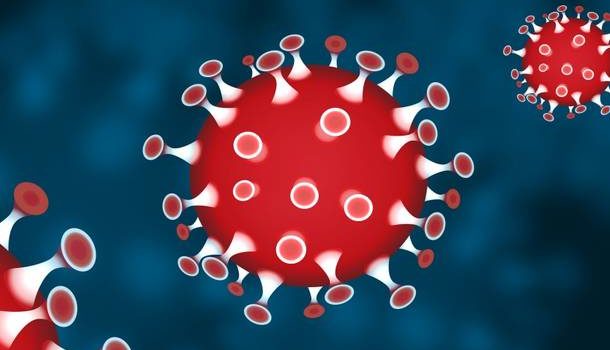
Altro che dono…
A quelli che pensano che questo virus sia un “dono” della Terra per purificarci (dal Male? Dallo smog? Da cosa esattamente?), rispondo che in molti ne avrebbero fatto volentieri a meno. Oltre 30mila persone sarebbero ancora vive e molti di noi avrebbero ancora un lavoro.
Altro che dono. A me sembra un “castigo” (ma non tirate in ballo Dio).

Voglio il mio vero caffè!
Con la (semi)liberazione del 4 maggio, una prima vera conquista, una prima vera parvenza di libertà l’abbiamo ottenuta: il caffè al bar.
Ovviamente, non il vero caffè seduto nel mio bar preferito, con lo zucchero a portata di mano, la scollatura della barista a portata di occhi e la Gazzetta dello Sport a portata di…cervello. Quello è il mio sogno, quello è il mio vero caffè che voglio! Ma, per lo meno, abbiamo potuto riassaporare il gusto del caffè del bar, sebbene da asporto, sebbene in un bicchierino di carta, sebbene da consumare velocemente e furtivamente fuori dal bar, quasi come dei ladri, sebbene senza Gazzetta dello Sport, sebbene senza la scollatura della barista – ora in cassa integrazione – e sostituita dal barbuto proprietario. Meglio che niente!
Ma come mi è mancato il caffè al bar! E’ la cosa che mi è mancata di più, durante questa maledetta quarantena! Anche il bar in piedi, al banco, all’italiana…certo che mi è mancato!
Ma che ne sanno gli stranieri che vogliono sempre sedersi al tavolino del bar, come se fossero al Florian di Venezia anche se si trovano a Pinerolo o a Formigine!? Se sapessero il gusto corroborante di energia pura di un caffè in piedi al bancone del bar……
Ecco, ora lo aspetto: al bancone o al tavolino, non importa. Io voglio il mio vero caffè!








