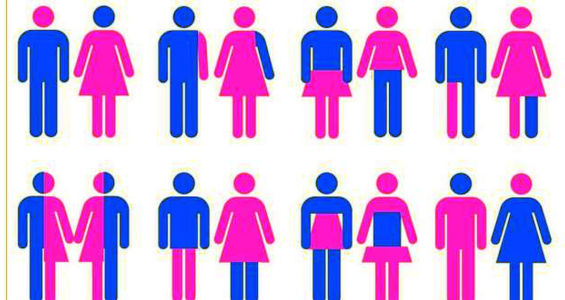Articolo di Francesco Costa, vicedirettore “Il Post”.
Queste nuove giornate stanno cominciando ad assumere una loro forma. Per esempio, per un po’ di persone ogni giornata è scandita dalla conferenza stampa con cui intorno alle 18 la Protezione Civile diffonde i dati quotidiani sul numero di persone contagiate, morte, ricoverate e guarite. Tante altre cose che compongono le nostre strane giornate sono una conseguenza di quei dati: a cominciare dai titoli, i grafici, i flussi e gli scenari che vediamo fiorire in televisione, sui social network e sui giornali, e che permettono a tutti di fare delle ipotesi, di sostenere delle tesi, di ipotizzare evoluzioni e interventi. I dati sono la nostra bussola: chiusi in casa, sono l’unico modo che abbiamo per provare a capire quello che sta succedendo.
Il problema è che quei dati ci dicono sempre meno.
Innanzitutto capita che quei dati siano incompleti. Una volta manca la Campania, una volta la Puglia, una volta Trento, una volta la Lombardia; altre volte i dati non sono ufficialmente incompleti ma presentano incongruenze che vengono corrette il giorno successivo. Nonostante queste occasionali ma frequenti incompletezze, quei dati vengono comunque commentati e analizzati, e ispirano discussioni sul picco che arriva o non arriva e quando arriva, sulle regioni messe meglio o messe peggio, su quello che ci aspetta. Poi il giorno dopo arrivano dei nuovi dati e si ricomincia, anche se a volte quei nuovi dati raccontano una storia molto diversa per una provincia o una regione intera.
Soprattutto, però, ci sono ragioni fondate per pensare che questi dati – al di là dell’incompletezza a volte dichiarata – non abbiano più una vera aderenza con la realtà: che siano così parziali da non poter più essere una bussola.
Abbiamo accettato da tempo – per quanto dubito che sia noto alla grande maggioranza degli italiani – che in Italia si fanno i tamponi soltanto a chi presenta sintomi importanti. Dato che la COVID-19 si manifesta in forma grave soltanto in una minoranza delle persone contagiate, questo vuol dire che il dato della Protezione Civile rappresenta solo una fetta piuttosto ristretta delle persone contagiate in Italia, che sono almeno quattro o cinque volte quel numero. Di per sé questo potrebbe non essere un grosso problema: basta saperlo. Se il criterio con cui facciamo o non facciamo i tamponi rimane uniforme e costante, l’evoluzione dei dati può dirci comunque molto. Se testiamo tutti i pazienti con sintomi gravi, anche il dato dei morti può dirci molto.
Quel criterio però non è più uniforme né costante.
La linea sui tamponi cambia da regione a regione. Ci sono regioni che li fanno solo a chi ha sintomi gravi o è entrato in contatto con una persona contagiata. Ci sono regioni che negli ultimi giorni hanno deciso di estendere questi criteri e farli “a tappeto” o quasi, per esempio il Veneto. Ci sono regioni che non testano i familiari delle persone positive, nemmeno quando presentano sintomi importanti, altre che invece lo fanno. In Lombardia, la regione con la situazione più drammatica, si fanno i tamponi solo alle persone che arrivano in condizioni gravissime in ospedale; e ci sono tante persone, soprattutto nella provincia di Bergamo, che muoiono in casa prima di essere testate. Muoiono, probabilmente muoiono a causa del coronavirus, e non rientrano nei dati quotidiani sui morti.
«Da quello che sappiamo», ha detto un biologo oggi a Repubblica, «gli ospedali lombardi, ormai al limite del collasso, rimandano indietro moltissime persone con sintomi senza far loro il tampone. E quindi il numero di contagiati è ampiamente sottostimato. Ma come denunciano i sindaci del bergamasco, c’è una stima errata anche dei decessi. Molti ormai muoiono a casa senza tampone e non nelle terapie intensive, quindi non risultano conteggiati come decessi per Covid-19 nei resoconti ufficiali. L’unica cosa certa è che i dati in arrivo dalla Lombardia sono ormai inutilizzabili».
Insomma: la metà dei contagiati rilevati in tutta Italia è in Lombardia, e non si riescono a testare nemmeno tutte le persone con sintomi gravi. Capite bene che in un contesto come questo basta cannare i dati sulla Lombardia perché l’intero quadro nazionale perda senso. Li stiamo cannando, e quelli che arrivano dalle altre regioni d’Italia non sono uniformi né raccolti con gli stessi criteri. In Emilia-Romagna ci sono 4.525 contagi rilevati e un tasso di letalità del 10,1 per cento; in Veneto ci sono 3.214 contagi rilevati e un tasso di letalità del 2,9 per cento. Nelle Marche ci sono 1.568 contagi rilevati e un tasso di letalità del 5,9 per cento; in Toscana ci sono 1.330 contagi rilevati e un tasso di letalità dell’1,7 per cento. Questo perché ogni regione va in ordine sparso, e ogni regione somma ai suoi buchi di rilevamento i diversi buchi delle altre regioni. Stiamo effettivamente sommando le mele e le pere.
Ora, io ovviamente non credo che la Protezione Civile stia imbrogliando tutti, per carità. La situazione è eccezionale e mai vista prima, non abbiamo le risorse per fare test a tappeto, il sistema sanitario in certe regioni è già ora al collasso e dove non è al collasso era deficitario da prima. Non penso che stia accadendo una cosa da “censura cinese”. È una cosa importante. Al di là delle intenzioni, però, è importante anche notare che il risultato purtroppo è lo stesso. C’è un motivo per cui la comunità scientifica considera pericoloso e grave che un paese non fornisca dati affidabili sul contagio alla sua popolazione, e quel motivo non è la difesa dei sani principi democratici: il motivo è che altrimenti siamo ciechi. Altrimenti non abbiamo idea di come stia procedendo il contagio. Temo che ci troviamo in questa situazione, in Italia come in tanti altri posti del mondo: abbiamo un’idea a spanne, basata sulla situazione negli ospedali, ma solo quella. Quanti sono i contagiati: non lo sappiamo. Quanti sono i morti: non lo sappiamo.
È un problema innanzitutto perché parliamo di dati. Non di valutazioni, scenari o prospettive, bensì dati, numeri, cose a cui siamo abituati ad affidare una descrizione esatta della realtà. Uno è diverso da due che è diverso da dieci che è diverso da mille. Eppure i dati quotidiani della Protezione Civile hanno un legame con la realtà molto più approssimativo e vago di quello che siamo abituati a pretendere dai numeri (numeri che, non dimentichiamolo, sono persone). Nonostante questo diffondiamo comunque questi numeri, che saranno utilizzati per fare previsioni, modelli, studi scientifici, in Italia e all’estero.
Infine, a questi dati è evidentemente legato un pezzo importante della legittimazione politica delle più gravi restrizioni alle nostre libertà dai tempi di Benito Mussolini. Prevengo l’obiezione: i dati veri sono sicuramente molto peggiori dei dati che abbiamo. Vero. Ma lo scopo dei dati è darci una misura, bella o brutta che sia: è misurare quello che abbiamo intorno. Sulla base di quella misura stiamo prendendo decisioni politiche, economiche, sanitarie eccezionali. Quando saremo in grado di dire che queste restrizioni non servono più, se non abbiamo idea di dove sia il virus? Dovessimo scegliere in futuro di adottare delle soluzioni diverse, come potremo misurare la loro efficacia in confronto alle attuali? In teoria oggi basterebbe aumentare la capacità di fare test per far esplodere istantaneamente il numero ufficiale dei contagiati, anche se magari le persone in gravi condizioni sono diminuite.
Credo che la Protezione Civile, che sta facendo un lavoro straordinario in circostanze straordinarie, dovrebbe sforzarsi di sottolineare come i dati che presenta ogni giorno vadano presi con un paio di pinze grandi come una casa. Credo che i giornali stiano facendo bene – anche al Post ci stiamo provando – a indagare e raccontare la diffusione della malattia al di là del contenuto dei dati ufficiali. Quanto a noi, per qualche giorno ho osservato con fastidio il fatto che alle 18, all’ora del solenne bollettino di guerra della Protezione Civile, una bella fetta di persone – almeno qui a Milano – avesse fissato il momento delle canzoni, dell’inno nazionale e delle urla dal balcone. Oggi sono più indulgente.